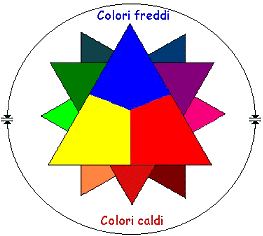Le nubi sono costituite da minuscole gocce d'acqua o da cristalli di ghiaccio della dimensione da 1 a 100 micron. Si formano per condensazione: quando l'acqua terrestre evapora, si trasforma in vapore acqueo che risale nell'atmosfera raffreddandosi, per condensarsi attorno a piccole impurità (cristalli di sale marino, particelle di polvere...) generando così goccioline d'acqua o cristalli di ghiaccio.
Questi elementi rimangono sospesi nell'aria sostenuti in movimento verso l'alto, possono evaporare e riformarsi, la loro velocità di caduta è di millimetri al secondo, quindi impercettibile e la quantità d'acqua condensata non supera il grammo per metro cubo di vapore acqueo. Le quantità variano secondo l'estensione verticale ed orizzontale delle nuvole.
Salvo casi di nubi con grande estensione verticale (i cumulonembi sviluppati), la nube non si svuota nel generare pioggia o neve, essendo continuamente alimentata da correnti di vapore acqueo. La grandine risulta, nei cumulonembi, un rimescolamento continuo di gocce d'acqua verso il basso poi verso l'alto, causato da violenti correnti verticali. Caricandosi continuamente di nuove particelle d'acqua, i chicchi di grandini possono assumere dimensioni considerevoli (sono stati osservati elementi da 1 chilogrammo) e cadere alla velocità di 8 metri al secondo.
L'aspetto delle nubi, cioè la forma, la densità e colori, dipendono dalla natura dei loro componenti e dalle condizioni atmosferiche: i contorni netti indicano in genere la presenza di grandi componenti, la trasparenza è indice di pochi elementi condensati, l'opacità caratterizza una nube molto spessa ed una struttura fibrosa e diafana è legata a cristalli finissimi.
Un'atmosfera stabile determina solo movimenti orizzontali e le forme sono distese; l'instabilità causa movimenti verticali con formazioni globulari. La posizione del sole sull'orizzonte determina riflessi e colori, che non sono legati ai componenti della nube.
Le nuvole hanno due forme caratteristiche, "stratificate" o "a sviluppo verticale": nel primo caso l'estensione si presenta maggiore sul piano orizzontale e minore su quello verticale (dalla rete).
Sebbene le nubi siamo in mutamento continuo, si identificano soltanto dieci principali generi di nuvole, classificati in base alla loro struttura, alla forma e all'altezza nella quale si formano, rispetto alla superficie terrestre:
Cirro - è il prefisso per nubi alte (sebbene le altezze varino secondo la stagione e la latitudine) - comprendono cirri, cirrocumuli e cirrostrati, che non portano precipitazioni.
Alto - è il prefisso per nubi che si formano ad altezza media, costituite da goccioline d'acqua e cristalli - comprendono altocumuli, altostrati e nembostrati
Ad altezza inferiore si trovano stratocumuli e strati, che recano precipitazioni leggere.
Due generi infine cumuli e cumulinembi, molto instabili e verticali, possono estendersi attraverso gli altri livelli
Il prefisso nimbo- e il suffisso -nembo indicano che la nube causerà precipitazioni.
lente dinamiche, nubi che sciamano
costellano il mio cielo mattiniero,
forme disgiunte, in controluce richiamano
quello che sono, quello che ero;
fu dolce adagiarsi nel nulla...
anonimo
del XX° secolo
frammenti ritrovati